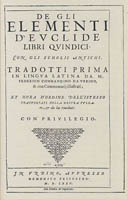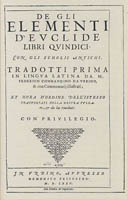 |
Federico Commandino
DE GLI ELEMENTI D'EUCLIDE
Urbino 2009
ristampa anastatica dell'edizione del 1575
Pagine 278
Nel 1543 Niccolò Copernico pubblica il De revolutionibus, evento, com’è noto, fondamentale dell’evoluzione moderna dell’astronomia e della cosmologia che troverà compimento, all’inizio del secolo successivo, con l’opera di Galileo e di Keplero e che corre parallela con i progressi del cosiddetto umanesimo matematico, con la riscoperta cioè dei testi della scienza matematica antica, rimessi in circolazione attraverso le cure filologiche ad essi applicate, le traduzioni in latino e in volgare, la diffusione attraverso la stampa. L’Occidente latino riconquista così un complesso di conoscenze cadute nell’oblio per un millennio e che ora, recuperate con piena consapevolezza, possono essere di nuovo fatte progredire.
Un ruolo di primo piano, in questo processo, è riconosciuto al matematico urbinate Federico Commandino (1509 – 1575), che dal 1557 al 1575 dà alle stampe ben dieci opere di matematici antichi. Con lui si compie il processo di riappropriazione della matematica greca, grazie soprattutto alle edizioni dei Conicorum libri di Apolonnio, delle Mathematicae collectiones di Pappo, del De iis quae vehuntur in aqua, del De centro gravitatis e delle opere matematiche di Archimede. Come esempio della ricaduta dell’opera del Commandino nei confronti del generale progresso delle scienze basterà ricordare che, per stabilire le orbite ellittiche dei pianeti, Keplero si servirà di teoremi illustrati nelle versioni commandiniane delle Coniche di Apollonio e degli Sferoidi di Archimede.
Gli Elementi di Euclide tradotti e commentati dal Commandino costituiscono un riferimento fondamentale per il Rinascimento scientifico italiano ed europeo. Le pagine dei Prolegommeni, che aprono il volume, figurano come il ‘manifesto’ programmatico della comunità scientifica urbinate; sono pagine che intendono rivendicare l’importanza e la funzione della nascente scienza e nel contempo indirizzarne la concezione, che affermano una scienza dotata d’incredibili potenzialità di sviluppo, di forte e contagiosa vitalità, profeticamente consapevole del grande futuro che l’attende.
Il volgarizzamento del Commandino rispondeva inoltre all’esigenza di mettere a disposizione del vasto pubblico di coloro che non padroneggiavano il latino – architetti, ingegneri, artigiani, tecnici, curiosi – un testo aderente all’originale greco, contribuendo così a un’ampia alfabetizzazione scientifica. In tal senso l’opera costituisce un passaggio importante per la formazione della terminologia scientifica italiana. |